Mercoledì 12 marzo, presso l’ex convento di San Francesco di Pordenone, la regista teatrale Serena Sinigaglia ha diretto l’attore emergente Tindaro Granata nella mise en espacede “Il libro del buio” di Tahar Ben Jelloun. È una delle tante storie vere che l’autore narra nei suoi romanzi, raccogliendole dalla voce dei protagonisti, in questo caso da un ex detenuto di Tazmamart. Salim, apparteneva al commando militare che il 10 luglio 1971 irrompe nella residenza estiva del re a Skhirate. Il colpo di Stato fallisce e i soldati vengono imprigionati: diciotto anni nelle tenebre più assolute.
Buio, luce soffusa, una bottiglia d’acqua e una pila di sacchi di sabbia come unici elementi scenografici. Granata sale sul palco vestito completamente di bianco e ci ritroviamo immediatamente all’interno di una piccola cella sepolta nella terra . Ogni prigioniero è “un vivo che sopporta la vita nella prova che può finire solo con la morte”. Per sopravvivere, ognuna delle cinquantotto “creature di noia” si costruisce un ruolo. Incontriamo quindi Karim, un orologio umano: essere schiavo del tempo lo rende libero; Walkrine, l’esperto di scorpioni che finirà con l’essere la loro vittima; e infine il cantastorie Salim, le cui frasi sono per i compagni “un bicchiere di acqua pura”.
Granata modella voce e movimenti per caratterizzare ogni personaggio accompagnato da un efficace alternarsi di luci e musiche. Lo scarno scenario scandisce un tempo immobile: a ogni morte un sacco viene svuotato e rimane inerte sul palcoscenico come un cadavere. La sabbia impalpabile scivola via come il destino di ognuno: lentamente per chi si è consumato di inedia e sofferenza, e violentemente per chi ha non ha saputo affrontare un’oscurità senza stelle.
Salim non vuole cedere e sfida il tempo con le storie e la preghiera, “l’atto gratuito per eccellenza”. La fede è fondamentale perché almeno lo spirito possa sopravvivere in condizioni insostenibili per il corpo.
Lo spettatore si ritrova coinvolto e travolto dalle condizioni dei personaggi. Le parole di Granata sembrano ricoprirci della stessa polvere e sporcizia. L’oscurità della sala esaspera le urla disumane e amplifica le emozioni del pubblico. Infine, una luce insostenibile rappresenta la liberazione finale di Salim, che esce caricandosi sulle spalle i sacchi e i ricordi dei compagni.
La conclusione è paradossale e spiazzante. All’inizio della storia “ricordare significa morire” e i prigionieri cercano di estraniarsi dalla realtà. Alla fine Salim si rende conto che “peggio dell’orrore subito è la sua negazione” e ricordare è l’unico modo di mantenere viva la propria identità.
Alina Andries, Chiara Buzzi, Giovanna Buzzo, Liceo Grigoletti di Pordenone

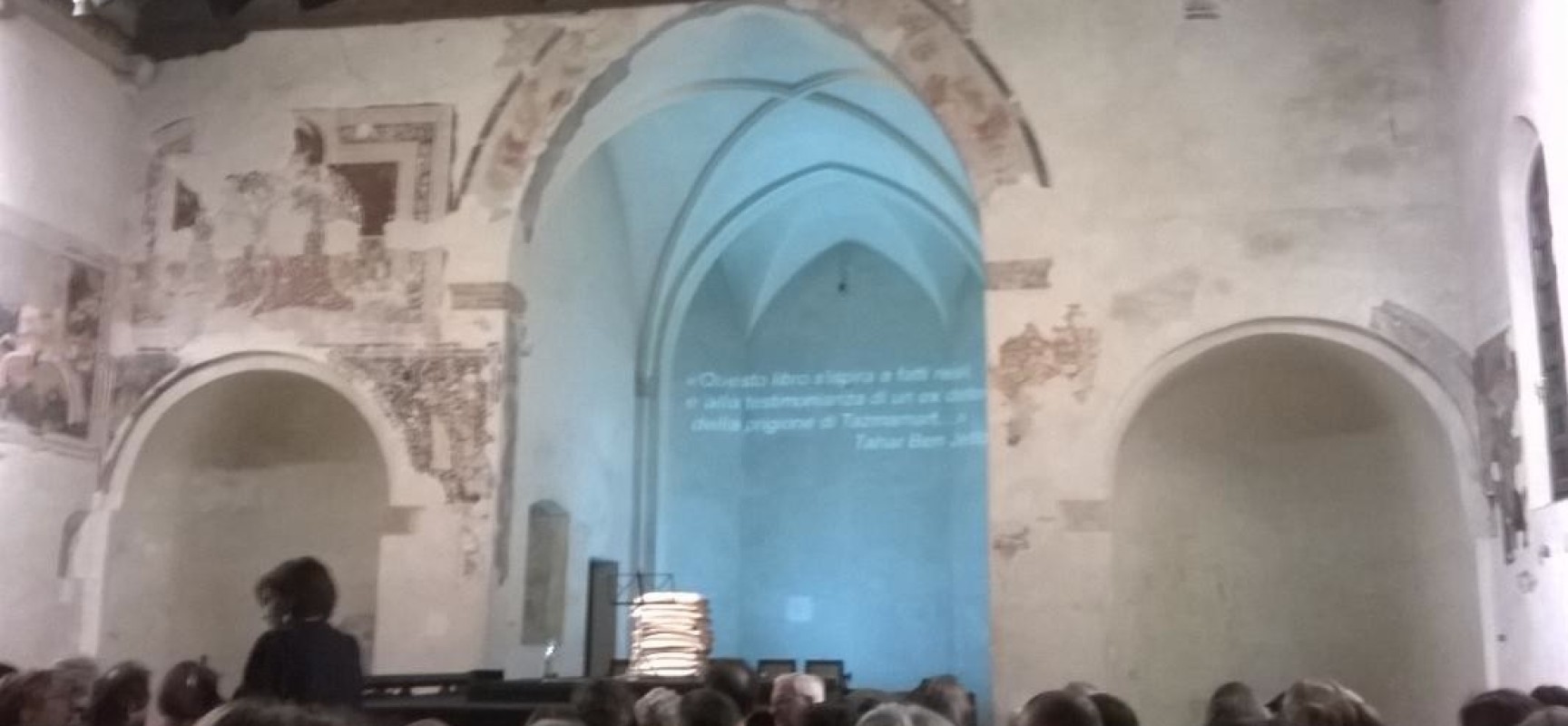






Nessun commento
Non ci sono ancora commenti, ma tu potresti essere il primo a scriverne uno.