
Paolo Rumiz legge alcuni estratti di “La Polvere del Mondo“, Nicolas Bouvier
Paolo Rumiz parla senza microfono.
Preferisce così, ci dice: è più intimo, la sala è piccola, i posti sono pochi, la sua voce non rimbomba. Arriva invece alle orecchie diretta e calma, come se avesse già cominciato a raccontare, e ascoltare viene naturale.
Mette a suo agio il suo approccio: si sta zitti e buoni perché lo si vuole, senza necessità di sentirsi obbligati. E allora ci si accomoda e si assorbe quanto letto, semplicemente.
De “La Polvere del Mondo”, libro di Nicolas Bouvier, legge brani che conosce benissimo – “Lo tengo sul comodino”, dice – e difatti non sdrucciola sulle lettere, non s’incanta, non sbaglia una pausa, come se raccontasse la sua storia invece di quella di qualcun altro.
In parte è così: Rumiz e Bouvier hanno vissuto in tempi diversi, con diverso itinerario, parte degli stessi luoghi e la stessa idea di viaggio e di ricerca dell’Oriente.
L’Oriente che si sogna perché, come ci ricorda, orientali e occidentali hanno gli uni degli altri un’idea mitologica – nessuno mostra all’altro, turista confuso o impiccione in buona fede, la propria vera faccia e la proprio vita quotidiana, ma piuttosto ciò che l’altro si aspetta di vedere.
Bouvier parte a bordo di una Topolino sgangherata, in compagnia di un amico pittore, col proposito di attraversare l’Oriente partendo dai Balcani. Di questi è descritta la vitalità e la realtà popolare, la vita dei giovani, quella dei contadini, ed ogni racconto è accompagnato da una descrizione dell’ambiente: natura e uomini si mischiano nel libro di Bouvier, sono realtà speculari che si influenzano a vicenda, al punto che fra i “sorbì e ciuffi di lillà” e le ragazze che, dormienti, sembrano belle finché non riaprono gli occhi, sembra esserci poca differenza dopotutto.
Sono figli della stessa terra, insomma, e come loro gli zingari che fra di loro suonano altra musica, cantano canzoni che non canterebbero ad alcuno straniero e sono fatte solo per loro, la loro lingua segreta e ancestrale fatta di suono, vitalità, gioia sfrenata.
Di ogni popolo viene descritta l’ospitalità: nei Balcani è entusiasta ed esuberante, tenera nel momento dell’addio: encomiabile è la descrizione della buffa, amorevole polacca Madame Wanda, proprietaria dell’albergo che li ha ospitati.
Dopo i Balcani incontriamo l’Anatolia, terra ruvida, caratterizzata da contadini altrettanto ruvidi e schivi con “facce da assassini“. Vengono descritti per la prima volta mentre suonano, anche loro, la loro musica, eppure non vi entra un briciolo della vitalità balcanica e di tutta quella gioia – piuttosto un senso di eterna tensione crescente, crescente, crescente in eterno; è in questa terra che Bouvier riscoprirà la paura ed il senso continuo di allerta che sembra così tipico della gente del luogo e delle città color terra, forti di massicce, antiche fortificazioni consumate, popolate da soldati, animate da continui controlli, raddolcite solo dalle cupole colorate che ne spuntano qua e là.
Dell’Anatolia si dice che è chiusa, primitiva. I maestri di scuola sono severi e nervosi, come se l’incontro con i forestieri fosse per loro una sorta di esame: in particolare imbarazzo è il maestro di francese, che si ritrova a dover ripetere più volte fra sè le poche frasi da rivolgere ai due svizzeri.
Dopo la Turchia s’incontra l’Iran e la singolare eleganza persiana, che passa anzitutto dal cibo: dove la cucina turca è sostanziosa, quella iraniana è semplice e fine. Ogni cosa attorno ai viaggiatori ora sembra contenere millenni di storia, in ogni morso di pane al sesamo c’è il sapore di un impero; nelle cose più semplici e quotidiane come il tè, le cipolle, il pane, appunto, il sapore delle sigarette, persino gli scarti di macelleria a loro regalati, si ritrova un segreto, voluttuoso lusso.
Lì un americano tenta di costruire una scuola: fornisce i materiali, il terreno, le consulenze, tutto ciò che può servire, lascia ai popolani il solo compito della manodopera, convinto di far loro un gran bene. Ma non è ben accolto; i lavori sono fermi ancor prima di cominciare e i materiali spariscono, nessuno si cura di questo progetto. In quella terra insegnano solo gli Imam, e i contadini s’interessano principalmente di poter mangiare di più, di non ammalarsi, di evitare le prepotenze dei poliziotti – non certo di una nuova scuola.
Incontrano carovane di nomadi che si spostano con le famiglie, il bestiame, i bagagli; incontrano i meccanici del luogo, che riparano tutto ciò che in Occidente verrebbe considerato poco più che un rottame; incontrano la bellezza su una terrazza di città – vi dormono – quando questa esce dalla propria stanza nella notte per bere al fresco otre d’acqua e guardare le stelle, senza accorgersi d’essere vista. Si dirà che in quel paese “Tutto ciò che è giovane e desiderabile si vela, si nasconde o si tace“.
Incontrano il deserto. L’odio per l’Iran quando in altri momenti v’era per esso amore. Incontrano il fascino di questa bellezza in declino, quello che era una volta un enorme impero.
Incontrano le mosche, mosche caparbie e accanite come mai se ne incontrano in Europa, e zanzare provette nel loro mestiere.
Emblematico è sul finire della lettura l’incontro di Bouvier con un Imam ventenne sul cassone di un camion: condividono del melone e qualche sigaretta e parlano di religione. Cristiani e musulmani sono “cugini in religione”, si può dire: grandi monoteisti entrambi, entrambi conoscono la figura di Gesù, simili poi per molti aspetti sebbene si siano dati vicendevolmente la caccia per secoli. Ma dopotutto la parola “cugino“, nella lingua del posto, somiglia alla parola “nemico“.
Rumiz termina l’incontro recitando una poesia in triestino: parla di un uomo che, partito senza ben sapere perché, dopo avere a lungo viaggiato e aver visto molti paesi lontani, decide che dopotutto casa sua è meglio.
Ma se anche fosse così, ciò che dall’incontro si evince è che non è poi male andarsene a casa di qualcun altro per un po’: potrebbe piacere comunque.

Paolo Rumiz
A fine incontro abbiamo avuto l’occasione di porre a Rumiz ancora una domanda, abbiamo dunque chiesto quali consigli si sentisse di dare a chi voglia come lui e come Bouvier viaggiare e visitare luoghi lontani, dove s’incontrano culture differenti.
Ha ricordato anzitutto che la cultura diversa la si ritrova ogni giorno sotto casa: basta guardarsi attorno e fare qualche domanda per scoprire un mondo diverso dal nostro.
Bisogna poi scegliere con attenzione il luogo verso cui ci si dirige: ne esistono di più difficili, di più pericolosi o di più ospitali.
Ovunque si vada, ha aggiunto, è bene imparare la lingua: un centinaio di parole sono sufficienti a far capire a chi è del posto che si arriva da loro con rispetto, che anche avendo l’inglese a disposizione si cerca di essere più vicini, più rispettosi. Allo stesso modo è utile parlare la propria lingua, mostrarne il suono, i gesti, la musicalità, e confrontarsi.
Infine, ha detto, si viaggi leggeri, e si viaggi senza fretta.
Si può aggiungere all’incontro un ultima considerazione: se la generazione corrente non avesse già fama di avida e curiosa viaggiatrice, questo libro, questo incontro, questo tipo di presentazione la farebbero subito balzare in piedi ed esclamare “Quando si parte?”
Bianca Martinetto
Bianca Ceragioli
Liceo Classico Vincenzo Gioberti





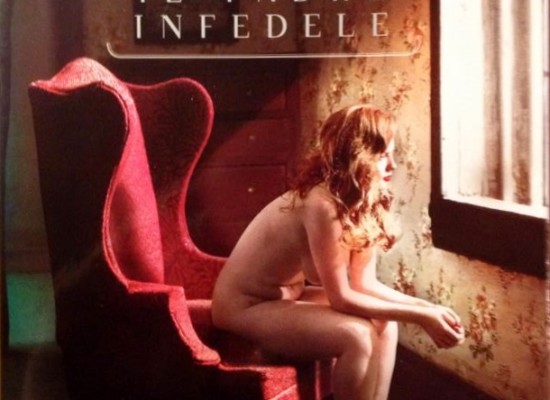


Un bel viaggetto in Iran lo farei subito! Bello l’articolo.
Grazie, è bello vedere che le persone sono sinceramente interessate agli articoli del SaloneOff